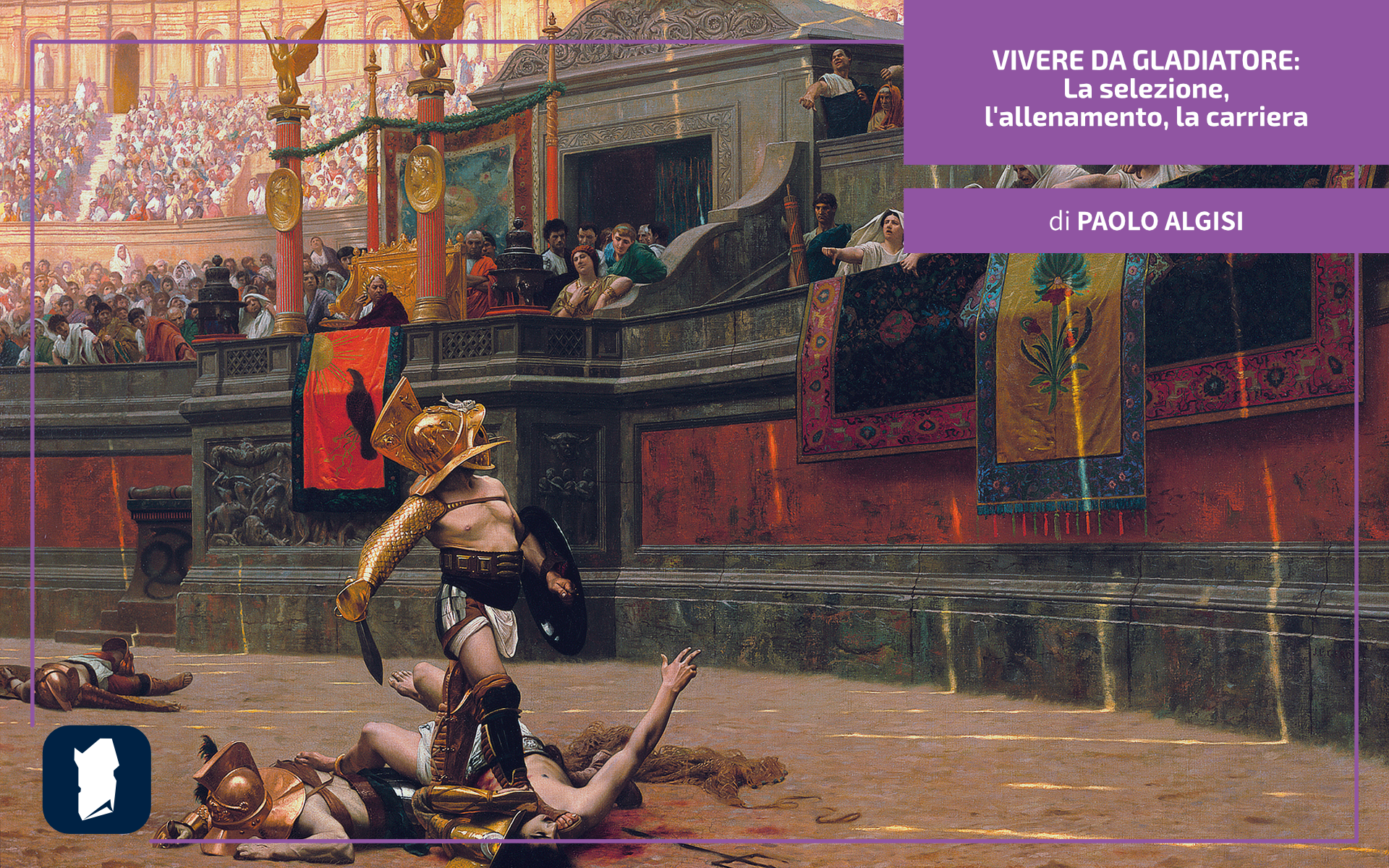Gichin Funakoshi, il fondatore del Karate-dō
Premessa
Gichin Funakoshi non fu solo il fondatore del karate-dō, ma seppe inoltre infondere a quest’Arte il suo senso della vita. Le tecniche e i rudimenti del Karate-do iniziarono ad esistere, come tutti sanno, quando Funakoshi li organizzò in un tutto coerente.
Fu proprio la visione e l’impegno personale del suo carattere a dare forza e senso globale ad uno stile che si è consacrato come uno dei punti di riferimento delle Arti Marziali in tutto il pianeta.
Per questo motivo conoscere a fondo la concettualizzazione del Karate di Funakoshi non è uno sforzo inutile, oggigiorno sono pochi gli studenti del Karate che conoscono le formule originarie della loro Arte, forse, per alcuni può sembrare persino anacronistica la pretesa di questo articolo.
Chi non conosce il passato, difficilmente potrà affrontare il futuro
Funakoshi fu un uomo con una personalità molto particolare, e per avvicinarci al Funakoshi uomo, alla sua personalità non c’è niente di meglio che leggersi la sua autobiografia Karate-Do, Il mio cammino, ormai tradotta in quasi tutte le lingue.
In essa troviamo un uomo semplice, non un intellettuale. Un uomo con una morale retta e ben definita, con principi che delineano una forte spina dorsale dalla quale sgorga un carattere forte e leale alle proprie convinzioni.
Senza dubbio non dovette essere facile avere a che fare con lui in vita: tuttavia era una di quelle personalità magnetiche, un leader nato, capace di trasmettere all’esterno il suo messaggio attraverso una forte impronta, e benché l’Arte che lui definì assomigli poco alle forme ed ai principi che conosciamo oggi come Karate, non va dimenticato che la sua evoluzione sarebbe stata impossibile senza un punto di partenza fermo e stabile, come quello che il Maestro seppe imprimere alla via della mano vuota.
Venti principi che definiscono la formale etichetta e l’atteggiamento che devono esistere nella pratica dell’Arte
Per questo è essenziale comprendere uno dei suoi lasciti principali, sfornati dal suo Dojo Kun, venti principi che definiscono la formale etichetta e l’atteggiamento che devono esistere nella pratica dell’Arte, affinché l’allievo raggiunga l’eccellenza, anticamente questi principi si recitavano a voce alta prima di ogni lezione, una pratica persa perfino nei Dojo più tradizionali.
Recitati come una litania, gli allievi li conoscevano a memoria e pur senza capirli, nel loro apprendistato, continuavano a poco a poco ad integrarne il senso e la ragione d’essere, l’articolo che oggi sto scrivendo, cerca di addentrarsi nel senso e nelle ragioni nascoste di questi venti punti, per facilitare ai più giovani una comprensione più profonda e completa delle origini essenziali della loro Arte Marziale e per ricordare ai più maturi, sia in età che in esperienza, la provenienza, i fondamenti della nostra tradizione Marziale.
Funakoshi, uomo di poche parole e di ancor meno spiegazioni, sosteneva che quello che impari con il tuo corpo non lo dimentichi mai, mentre quello che impari con la tua testa è facile da dimenticare. Senza dubbio il Maestro non immaginò nemmeno che, negli anni seguenti, la testa sarebbe servita (in troppi casi) solamente a reggere il cappello, perciò senza ribattere il fondatore, vorrei analizzare uno ad uno i punti ed il relativo significato, un’eredità piena di valore ora e sempre, un ulteriore regalo del fondatore al quale i Karateka devono sempre rispetto e gratitudine.
I · IL KARATE-DO COMINCIA E FINISCE CON IL SALUTO
La gentilezza ed il rispetto si dimostrano e si acquisiscono anche con la pratica. Salutare è ricordare al nostro corpo che deve obbedire ad alcuni criteri, nei quali il rispetto deve sottomettere altri impulsi che, senza dubbio, si attivano nella pratica (aggressività, paura, etc).
Dominarli è uno dei compiti dell’artista marziale, ma oltre alla cortesia, il saluto Orientale chinando il capo, possiede un senso simbolico e persino energetico poco diffuso, o, che poi è la stessa cosa, piuttosto dimenticato, chinando il capo, sia in posizione Seiza che stando in piedi, unifichiamo i principi di Cielo e Terra.
I principi e le loro energie che penetrano il nostro corpo attraverso la colonna vertebrale (dischi e genitali) come due serpenti di forza, in Seiza le mani devono unirsi contemporaneamente (non prima una poi l’altra), creando un triangolo formato tra i pollici e gli indici, tra i quali si deve collocare la fronte.
La cortesia significa contenimento per reindirizzare gli istinti, la sua ripetizione risulta sempre educativa ed organizzativa per le gerarchie, il saluto al Maestro ha questo significato, il saluto con il tuo contendente riconfigura lo spazio formale del combattimento apportandovi dei limiti, ricordandoci che il nemico è dentro di noi, non fuori.
L’altro è solo uno specchio (un’opportunità di presa di coscienza ), nel quale le nostre limitazioni si vedranno rispecchiate, il quale non è, dunque, il colpevole di esse.
II · NON UTILIZZERAI MAI IL KARATE-DO SENZA MOTIVO
Sun Tsu comincia il suo libro sulla Guerra avvertendoci: “La Guerra è un tema di vitale importanza, il territorio della vita e della morte, non deve essere affrontato alla leggera”.
Giustificare l’aggressione è un argomento filosoficamente complesso, per Funakoshi l’aggressività si spiega solo come atto difensivo, la violenza gratuita era continuamente criticata dal Maestro, oppostosi perfino al Ju Kumite (combattimento libero) che suo figlio invece propugnava.
Inoltre, il Karate è persino un allenamento della personalità, dello spirito dell’allievo che allena il suo carattere ed il suo corpo per raggiungere uno stato di allerta e di eccellenza, non per ostentare le sue abilità o per dimostrare a sé stesso o agli altri qualcosa.
III · PRATICARE IL KARATE-DO CON SENTIMENTO DI GIUSTIZIA
Rafforzando il punto precedente, il Maestro aggiunge inoltre che la pratica del Karate ed il suo utilizzo devono servire solo cause giuste, con atteggiamenti impeccabili, allo stesso modo, in questo punto Funakoshi ammonisce coloro che pretendono di utilizzare il Karate e le sue conoscenze al servizio di ignobili cause.
Per gli Istruttori, la selezione degli allievi e delle loro intenzioni nell’apprendimento dell’Arte era una delle sue principali preoccupazioni e, sebbene oggigiorno il potente Cavaliere Denaro abbia abbassato i parametri limitando l’entrata solo a coloro che pagano la retta mensile, è giusto ricordare che abbiamo una responsabilità aggiunta nell’esercizio dell’insegnamento dell’Arte.
IV · PRIMA DI CONOSCERE GLI ALTRI BISOGNA CONOSCERE SE STESSI
Esattamente come recitava il testo scritto nel portico dell’Oracolo di Delfi “Conosci te stesso“, Funakoshi stabilisce qui uno dei principi essenziali della via del Guerriero, “Niente fa niente a nessuno! “ invece di nasconderci incolpando continuamente gli altri delle circostanze negative della nostra vita,Funakoshi per prima cosa ci intima di guardarci dentro ed, in questo modo, di assumerci la responsabilità per i nostri atti .
Invece di perdere tempo a tentare di fuggire dalle nostre miserie evidenziando le altrui, il Maestro ci chiede rigore nei nostri giudizi, guarda prima te stesso, poi te stesso, poi ancora te stesso e, dopo esserti guardato dentro, rifallo ancora una volta, e solo a questo punto considera gli altri.
V · DALLA TECNICA NASCE L’INTUIZIONE
Questo è un principio spesso mai interpretato in Occidente, molti credono che sia la tecnica in sé ad essere importante, tuttavia dobbiamo partire dal fatto che per gli orientali il valore delle cose sta nella loro forma.
La tazza esiste ed ha un’utilità nella misura in cui possiede uno spazio in grado di contenere.
La ruota rotea e sostiene la propria struttura perché possiede uno spazio tra i raggi, la tecnica è dunque “la forma“ che ci conduce al movimento naturale, non un busto stretto che strangola la nostra fluidità, tuttavia, per raggiungere tale abilità è necessario allenare la tecnica per alla fine realizzare la conoscenza attraverso il vincolo con “il naturale”.
Così Funakoshi ci ricorda che la pratica di una forma tecnica corretta, ci collegherà alla nostra conoscenza essenziale con l’intuizione, per fluire in modo naturale con le infinite circostanze.
VI · NON LASCIATE VAGABONDARE LO SPIRITO
La concentrazione è in ogni pratica Orientale un principio insostituibile, quando il duro allenamento esercita una pressione sufficiente, la mente tende a vagabondare, ad allenarsi, per interrompere lo sforzo.
Funakoshi era un uomo di abitudini e principi solidi ed ordinati, conoscitore del fatto che tutto comincia in Yin, mantenerci fermi nel qui e adesso è essenziale per la pratica del Karate come via di coscienza.
La routine e le ripetizioni dell’allenamento sono una dura prova per la concentrazione, l’allievo deve evitare la dispersione mentale e la meccanizzazione del movimento, solo essendo presenti, le tecniche possiedono la forza e l’intensità adeguate, solo concentrati nella loro applicazione possiamo ricaricare i nostri sistemi di forza, per concludere l’allenamento più forti di quando l’abbiamo cominciato.
VII · IL FALLIMENTO NASCE DALLA NEGLIGENZA
Per il Maestro non ci sono casualità, non ci sono “Ma” e non ci sono “Se”! Con questo punto il Maestro rafforza il precedente, l’attenzione, l’impegno sono essenziali nella pratica.
Non servire adeguatamente le parti che formano il tutto, farlo con deficienza, senza l’attenzione dovuta o senza lo sforzo necessario, conduce al fallimento, il fallimento non è una disgrazia che cade arbitrariamente dal cielo, ma anzi è sempre il risultato della distrazione, della disattenzione, dell’abbandono, della negligenza, dell’apatia o della trascuratezza.
Funakoshi ci ricorda che siamo responsabili dei nostri atti e dei suoi risultati, aprendoci così la porta delle possibilità di miglioramento e di crescita, l’evoluzione esiste a partire dal continuo errore, perciò il guerriero si alza ad ogni caduta con la certezza che, se corregge il suo errore, potrà raggiungere il suo obiettivo.
VIII · IL KARATE-DO SI PRATICA SOLO NEL DOJO
Il Dōjō è letteralmente “il posto del risveglio“ , il Karate-dō , non è una pratica utile ad attaccarsi per le strade, il suo obiettivo non è sottomettere gli altri, bensì rimodellare se stessi, per risvegliarci in una realtà dove il simbolico e il reale sono una cosa sola.
Con questo principio il Maestro ci ricorda ancora una volta che non dobbiamo utilizzare inadeguatamente le nostre conoscenze, circoscrivendo la nostra pratica nello spazio sacro del Dōjō .
IX · LA PRATICA DEL KARATE-DO DURA TUTTA LA VITA
Come pratica spirituale, il Karate-do è un’Arte che fa parte per sempre della natura degli allievi, inoltre, recitando questa frase gli allievi rinnovano quotidianamente il loro impegno con l’Arte, dandogli lo spazio adeguato nel loro essere.
Come pratica dai lunghi e lenti risultati, il Karate richiede un impegno durevole per raggiungere i suoi obiettivi e togliere il velo che nasconde i suoi tesori, perciò il Maestro in questo principio, ripete la necessità in un impegno per tutta la vita.
X · AFFRONTO I PROBLEMI CON LO SPIRITO DEL KARATE-DO
Ancora una volta comprendiamo attraverso un altro principio, che il Karate do come Arte trascende l’ambito del puramente fisico o sportivo, il Karate è un modo di vivere, un modo di affrontare le cose .
Quando Funakoshi ci intima di affrontare i problemi con spirito del Karate do, ci ricorda che siamo guerrieri ventiquattro ore al giorno, non solo quando siamo sul tatami , in questo modo il Karate do è implicato in tutti gli avvenimenti dell’esistenza del praticante, in modo tale che le virtù che l’adornano debbano attivarsi davanti alle avversità con autocontrollo, responsabilità, forza di superamento, rispetto ed impegno.
XI · IL KARATE-DO È COME L’ACQUA CHE BOLLE
L’acqua è un argomento ricorrente ed essenziale nella tradizione nipponica, esistono duecento termini differenti per dire acqua in funzione dello stato e delle circostanze che la circondano.
L’acqua è il principio della vita e l’essenza della sua natura è andare verso il basso, fluire, avvolgere, non opporsi.
Quando Funakoshi cita l’acqua nel suo stato di ebollizione, ci sta parlando dell’acqua nel suo stato “legno“, facendo riferimento ai cinque elementi chiamati GO KYO in Giappone.
Il legno si caratterizza per essere la forza di volontà e l’acqua in ebollizione si trasforma così nella realizzazione opposta della sua natura, attivandosi sale invece di scendere, cercando l’evaporazione, quest’attivazione della natura dell’acqua è il fuoco di consapevolezza che sorge dallo sforzo del praticante.
Perciò il praticante deve essere capace di rimanere in uno stato fluido ma attivo, sempre pronto a rispondere ad un attacco.
XII · NON ALIMENTATE L’IDEA DI VINCERE NÈ QUELLA DI ESSERE VINTI
Questo punto è quello che ha generato la tanto discussa polemica se il Karate debba essere o meno praticato in competizione.
La cosa essenziale in questo ambito risiede nell’atteggiamento corretto dell’allievo.
Se collochiamo l’obiettivo all’esterno infatti, senza dubbio non lo stiamo collocando all’interno.
Ma tale decisione è più uno stato d’animo che un atto definito, per il Maestro, il Karate è innanzitutto una via interna, come cammino verso l’auto-superamento nel Karate, i risultati esterni non possono essere il suo fondamento.
Pertanto il nemico non sta fuori bensì dentro di noi, ogni volta che rispondiamo solo esternamente, staremo trascurando la vera ragione d’essere dell’Arte.
XIII · ADATTARE L’ATTEGGIAMENTO A QUELLO DELL’AVVERSARIO
Bisogna evitare le formule preconcette nella vita, essere flessibili, adattarsi sempre alle circostanze, la pratica dell’Arte non è l’applicazione di formule, bensì la risoluta conquista delle risorse necessarie per fluire costantemente oltre le nostre limitazioni.
“Ogni toro ha la sua corrida“ recita il detto taurino, perciò quelli che pretendono di usare sempre la stessa tecnica davanti a diversi rivali saranno sconfitti.
XIV · IL SEGRETO DEL COMBATTIMENTO RISIEDE NELL’ARTE DI SAPER DIRIGERLO
Il combattimento come dice Sun Tsu , è un tutto dove regna l’apparente disordine, tuttavia l’esperto sa comprendere le chiavi nascoste utili ad ordinarlo, è possibile dirigere, perché nel mezzo dell’apparente caos dobbiamo capire che non solo esiste un ordine, ma che può essere diretto da un centro.
Comprendere che il centro della spirale dirige la sua periferia, sia nello spazio che nel tempo, è la chiave Maestra che ci propone Funakoshi ricordandoci che tutto questo è possibile e ci intima a cercare quei ritmi essenziali che dominano ogni contesa, per diventare padroni del ritmo del rivale affinché balli secondo la nostra musica.
XV · LE MANI E I PIEDI DEVONO COLPIRE COME SCIABOLE
Qui il Maestro sottolinea la conoscenza delle spirali come le forze e i movimenti più potenti e naturali.
Einstein ci aprì gli occhi comprendendo l’affermazione per la quale la linea più vicina a due punti è quella retta, non sarebbe stata sempre corretta, la stessa conformazione delle nostre braccia sorge nel periodo embrionale da due spirali che derivano dalla collisione delle forze Cielo e Terra, che generano l’embrione.
Nella loro polarizzazione che è la crescita, queste forze sviluppano due paia di spirali di sette giri che generano le braccia e le gambe, una è più lunga, Yin (le gambe), e l’altra è più corta, Yang (le braccia), la loro concezione e la loro architettura fanno si che ogni movimento circolare sia facilitato.
Per questa ragione la Katana giapponese è curva, di fronte alla maggior parte delle spade occidentali, la comprensione dei principi della spirale è incisa profondamente nella conoscenza popolare Orientale e spesso rappresentata nei suoi simboli, il Maestro ci ricorda con questo principio che dobbiamo agire in sintonia con la natura delle cose e non contro essa, aprendo con questa chiave la porta ad un principio che ogni allievo deve ricordare nel proprio apprendistato.
Una chiave per ricordare oltre ciò che il suo Maestro gli insegna.
XVI · SGOMBERANDO LA SOGLIA DELLA VOSTRA CASA 10.000 NEMICI VI ASPETTANO
Ancora una volta il principio dell’attenzione continua, l’attenzione deve chiudersi nell’entropia , niente di meglio perciò di mettersi alla prova, per questo il Maestro non insegna il suo trucco, state sempre in guardia! Così la vostra attenzione rimarrà all’erta.
I vietnamiti normalmente si ripetevano: “chi si aspetta il peggio, non prende mai l’iniziativa“, non so perché ma personalmente questa regola mi riporta sempre alla memoria un detto Orientale che mi piace molto: “Se una tigre fa la guardia al passaggio, diecimila cervi non passeranno“.
XVII · KAMAE È LA REGOLA PER IL PRINCIPIANTE, DOPO È POSSIBILE ADOTTARE UNA POSIZIONE PIÙ NATURALE
Kamae. Stare in guardia , attenti, in posizione, pronti a reagire.
Sanzionando la precedente affermazione, il Maestro ci ricorda che l’allenamento possiede dei gradi ed ha un’evoluzione, l’allenamento è come un imbuto dove devi passare, restringe la tua natura, prescindendo quindi dal non necessario, per poi tornare ad essere te stesso ma trasformato dall’esperienza.
È un modo di rendere naturale un viaggio di andata e ritorno nel quale il tuo bagaglio è la cosa imprendibile, i tuoi ricordi, le tue esperienze. Su questo punto ricordo il detto Zen:
Prima dello Zen, la montagna è montagna, la valle, valle, la Luna, Luna. Durante lo Zen la montagna non è più la montagna, né la valle, valle, né la Luna, Luna . Dopo lo Zen, la montagna ritorna ad essere montagna, la valle, valle, la Luna, Luna.
Niente è cambiato, tuttavia tutto è differente. Kamae è un atteggiamento con il quale si allena una chiave che apre una porta, non la stanza nella quale vuoi entrare, è il dito che indica la luna, non la luna stessa.
XVIII · I KATA DOVRANNO ESSERE REALIZZATI CORRETTAMENTE, TUTTAVIA NEL COMBATTIMENTO REALE I LORO MOVIMENTI SI ADATTERANNO ALLE CIRCOSTANZE
Di nuovo ci ricorda di essere flessibili, ma rigorosi.
I Kata sono la base della “Forma“, perciò è essenziale che nella loro pratica si allenino i movimenti con perfezione tecnica, non c’è contraddizione tra questo e combattere con movimenti che non riproducano quelli che si eseguono nel Kata, come sostengono alcuni maestri attuali.
Funakoshi lo disse chiaramente in questo punto, ancora una volta dobbiamo ricordare la posizione che assumono gli Orientali rispetto alle forme e che sviluppammo nell’analisi del primo punto del Dojo Kun.
Lo scopo del Karate-do non è quello di creare lottatori estremi, bensì sviluppare lo spirito od il corpo dell’allievo attraverso un allenamento che tiri fuori il meglio di lui, favorendo la positiva formazione di individui che possano, inoltre, essere elementi positivi per le loro società.
XIX · TRE FATTORI VANNO CONSIDERATI: LA FORZA, LA CONSISTENZA ED IL GRADO TECNICO
Davanti ad un compagno o di fronte ad un avversario Funakoshi ci ricorda i tre fattori che dobbiamo tenere in considerazione nella valutazione di noi stessi e di chi abbiamo di fronte, i primi due si riferiscono a considerazioni fisiche ed il terzo all’esperienza e alle conoscenze.
XX · APPROFONDITE IL VOSTRO PENSIERO
Probabilmente all’epoca, come adesso, gli allievi di Karate erano persone più d’azione che di riflessione, ma dato che tutto va visto nel suo opposto, il Maestro conclude le sue proposte con una chiara allusione allo sviluppo mentale degli allievi.
In questo piano di realtà tutto è mente o, con le parole di Carlos Castaneda, “Il Mondo è una descrizione“.
Non è vano, quindi, ricordare ad ogni praticante di Karate do di sviluppare le proprie abilità e le proprie conoscenze per crescere come persona, comprendendo la realtà che sta dietro le apparenze, riflettendo e meditando per completare il proprio apprendistato.
Conclusioni
Abbiamo visto in questa analisi che il Karate-do che propose il suo fondatore è una pratica trascendente, nella misura in cui può portarci oltre il simbolico, una via che apre porte e finestre per permetterci di capire e di agire giustamente, persino oltre le valutazioni morali.
Una via di crescita interna che sgorga all’esterno in risultati positivi
una formulazione della via del guerriero che ha saputo, in un modo o nell’altro, trovare un’eco quasi impensabile in quei giorni passati in cui il Maestro coniugò la tradizione Guerriera millenaria dell’Oriente con la comprensione e le formule iniziatiche proprie della tradizione nipponica, raggiungendo una formula Universale ed intensa che è durata, ha evoluto e trasformato migliaia di esseri umani nelle ultime decadi.
Benché oggi i suoi principi esposti nel Dojo Kun siano ignorati, essi rimangono vivi nella spirito che soggiace alle diverse pratiche negli svariati stili, trasformazioni e polarizzazioni di una stessa spirale iniziale, un punto di partenza fermo che ebbe un nome: Gichin Funakoshi .
Perciò, Maestro, con questo articolo voglio rinnovarvi la mia eterna gratitudine ed il mio riconoscimento
E per farlo, niente di meglio che ripensarti proprio quando tanti allievi pensano che tu sia antiquato.
Quello che loro non sanno, è che il classico in quanto tale è eterno e non può mai essere antiquato.
Note
- Foto di copertina File (Wikimedia Commons)
- Grafica copertina ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Redattore presso Nuova Isola. Istruttore di Arti Marziali qualificato. Cintura nera 8° Dan Karate Shotokan.